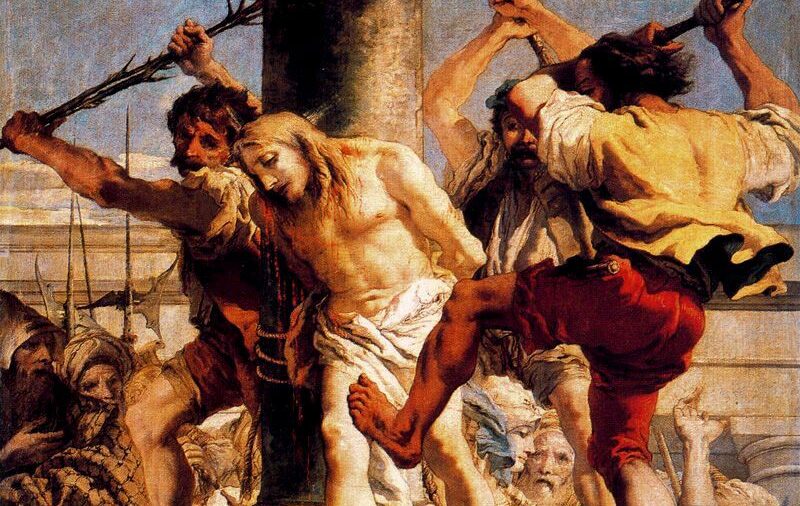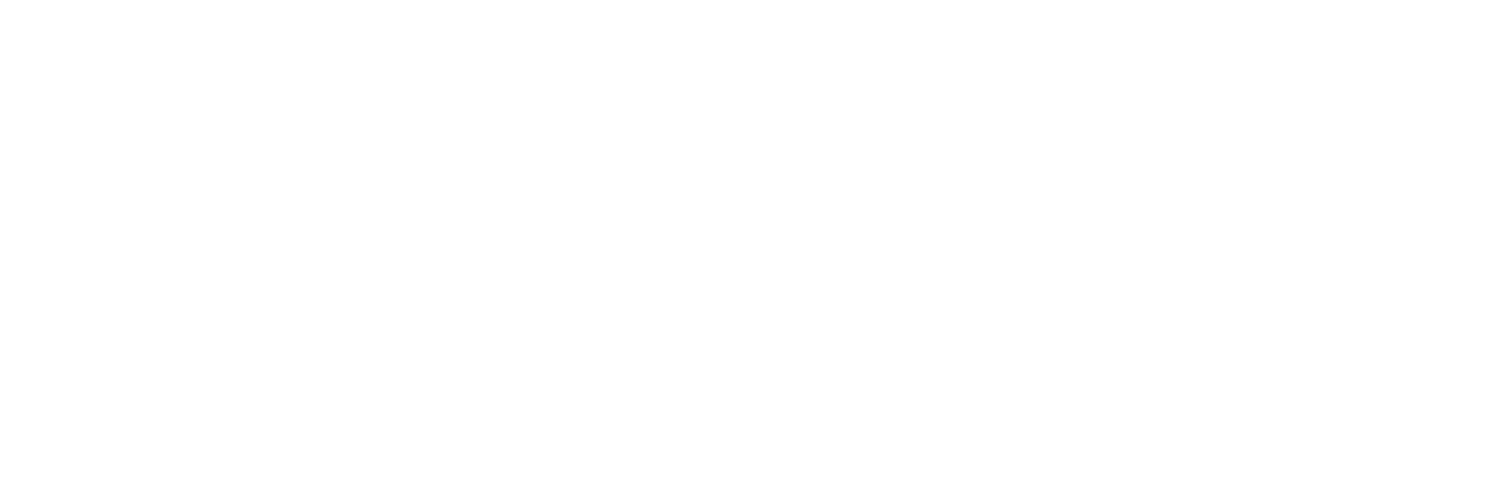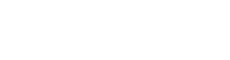La Summa theologica, capolavoro di San Tommaso
Nella sua breve, ma intensa vita San Tommaso ebbe a che fare con tantissimi studenti, che ascoltavano le sue lezioni di Magister nelle scuole teologiche dell’Ordine domenicano. Dalla sua attività di insegnamento sono nate le principali sue opere filosofiche e teologiche, il cui fine principale era quello di fornire una base per lo studio personale dei discipuli. Era, infatti, molto diffusa la pratica da parte dei magistri di comporre sintesi del loro insegnamento. Così nacque il Liber sententiarum di Pietro Lombardo, il manuale di teologia più diffuso in epoca medievale, cui anche San Tommaso fece riferimento.
Con la nascita della Scolastica nel XII-XIII secolo, poi, si diffuse il genere letterario delle summae, che costituivano dei veri e propri manuali, contenenti l’intero corso delle scienze teologiche. Le summae erano composte secondo il metodo usato nelle scholae, che consisteva nella proposta di quaestiones, cui il maestro rispondeva adducendo prima le prove in contrario (sed contra) e poi la loro risoluzione. Anche San Tommaso, principale esponente della Scolastica, utilizzò questo genere letterario, componendo la Summa contra gentiles e la Summa theologica. La Summa contra gentiles è una apologia della fede cristiana contro gli errori più diffusi all’epoca, in particolare quelli provenienti dai pensatori arabi (i gentiles). Gli argomenti vengono in essa trattati attraverso la dimostrazione ad absurdum aut ad inconvenientiam, che rende la lettura molto complessa e la comprensione faticosa.
La Summa theologica, invece, costituisce la sintesi del pensiero teologico tommasiano, in quanto ultima e più matura opera uscita dalla penna del Dottore Angelico. Afferma, infatti, p. James Weisheipl OP che essa «è il contributo più lungo e più importante dato da Tommaso alla scienza teologica. […] Fu, tra tutte le opere di Tommaso, la più diffusa sia in forma manoscritta sia in forma stampata. L’influsso che esercitò sulla vita e il pensiero cattolico fu grandioso».
Il Dottore Angelico impiegò ben sette anni della sua vita a comporre quest’opera, che purtroppo lasciò incompiuta, quando il 6 dicembre 1273, in seguito ad una rivelazione divina, che gli mostrò l’ineffabilità del mistero divino, decise di non scrivere più nulla. Secondo gli storici, già ne 1265 San Tommaso aveva concepito l’idea di scrivere una Summa di teologia per i principianti. Tuttavia, è certo che ne iniziò la stesura nel 1266, quando insegnava a Roma. È allo stesso modo certo che la Prima pars era già completa e messa a disposizione dei lettori prima che San Tommaso si trasferisse a Parigi nel gennaio 1269. Di conseguenza, si può dedurre che essa fu composta a Roma e a Viterbo tra il 1266 e il 1268. La Secunda pars, invece, impegnò l’intero periodo, in cui San Tommaso insegnò a Parigi, ovvero tra il 1269 e il 1272. Infine, la Tertia pars fu scritta a Napoli, nel convento di San Domenico Maggiore, tra il 1272, anno in cui il dottore tornò in Italia, e il 6 dicembre 1273, data in cui, come si è detto, decise di interrompere la sua attività redazionale.
Lo scopo principale, per cui San Tommaso iniziò a redigere la Summa theologica, è quello di comporre un trattato di teologia adatto ai principianti. Afferma, infatti, nel Prologo: «L’intento che ci proponiamo per mezzo di quest’opera è di esporre quelle cose che riguardano la religione cristiana secondo un modo che sia adeguato all’erudizione dei principianti (ad eruditionem incipientium)». Ciò è dovuto al fatto che molti discipuli nell’iniziare lo studio della scienza teologica incontravano numerosi ostacoli «in quelle cose che sono state scritte da autori diversi». Questi ostacoli sono, secondo l’Aquinate, di tre tipologie. Innanzitutto, le opere teologiche diffuse all’epoca erano, a suo giudizio, troppo prolisse e minuziose («per il gran numero di inutili questioni, articoli e argomenti»). In secondo luogo, non erano sistematiche nell’esposizione degli argomenti («le cose, di cui essi hanno bisogno per imparare, non sono esposte secondo l’ordine della disciplina»). Infine, a causa di questa mancanza di sistematicità, erano troppo ripetitive («la frequente ripetizione di quelle cose generava negli animi degli studenti fastidio e confusione»). San Tommaso, in conclusione, decise di redigere un manuale di teologia completo, sistematico e allo stesso tempo breve e di semplice comprensione, per aiutare i suoi discipuli e quanti volevano iniziare (incipientes) a studiare la teologia. L’umile fine del Dottore Angelico diede vita al più grande trattato di teologia di tutti i tempi, che ancora oggi, dopo otto secoli, rimane il fondamento sicuro di quanti vogliono approcciarsi allo studio della Sacra Dottrina.
La Summa theologica, composta secondo uno schema molto preciso e sistematico, è suddivisa, come si è accennato indirettamente nei paragrafi precedenti, in tre parti. L’opera inizia con una prima questio introduttiva, in cui San Tommaso si interroga sull’epistemologia della scienza teologica, ovvero sull’oggetto e la natura della teologia. La Summa segue poi un duplice movimento: partendo dall’esistenza eterna di Dio, si sofferma prima sull’exitus di tutte le cose dal Creatore e poi sul reditus di ogni essere creato a Dio come fino ultimo e cui tutto tende.
La Prima pars della Summa espone la dottrina su Dio uno e trino (De Deo uno, De Deo trino) e sulla creazione (De Deo creante). Questa prima parte contiene un’esposizione di estrema semplicità, pur mantenendo una profonda e completa concezione metafisica.
La Secunda pars tratta del «moto della creatura razionale verso Dio», ovvero espone quella che oggi viene denominata teologia morale. Essa è molto originale rispetto alle trattazioni coeve. Nella redazione dell’opera il Dottore Angelico la divise in due sezioni: la prima secundae tratta del moto dell’uomo verso Dio mediante le azioni umane in generale, mentre la secunda secundae tratta delle azioni umane in particolare. La Terzia pars, infine, tratta di Cristo, vero Dio e vero Uomo, unica via per tendere a Dio. In particolare essa espone la Cristologia (De Deo redemptore) e la teologia sacramentaria (De sacramentis in genere e in specie). Tuttavia, come si è già detto, questa parte della Summa rimase incompleta. Il testo si interrompe alla quaestio 90, sul sacramento della Penitenza.
Dopo la morte di San Tommaso il suo segretario, p. Reginaldo da Piperno, decise di completare l’opera del suo maestro e compose, insieme ai primi editori dell’opera, le quaestiones rimanenti in base agli appunti, che il Dottore Angelico aveva lasciato. Questa sezione è nota sotto il titolo di Supplementum e contiene le questioni restanti circa il sacramento della Penitenza, quelle sull’Estrema Unzione, l’Ordine Sacro e il Matrimonio e, infine, quelle sui Novissimi. Secondo quanto affermano gli stessi compositori, il Supplementum fu «messo insieme con forbici e colla usando parti degli scritti dell’Aquinate».