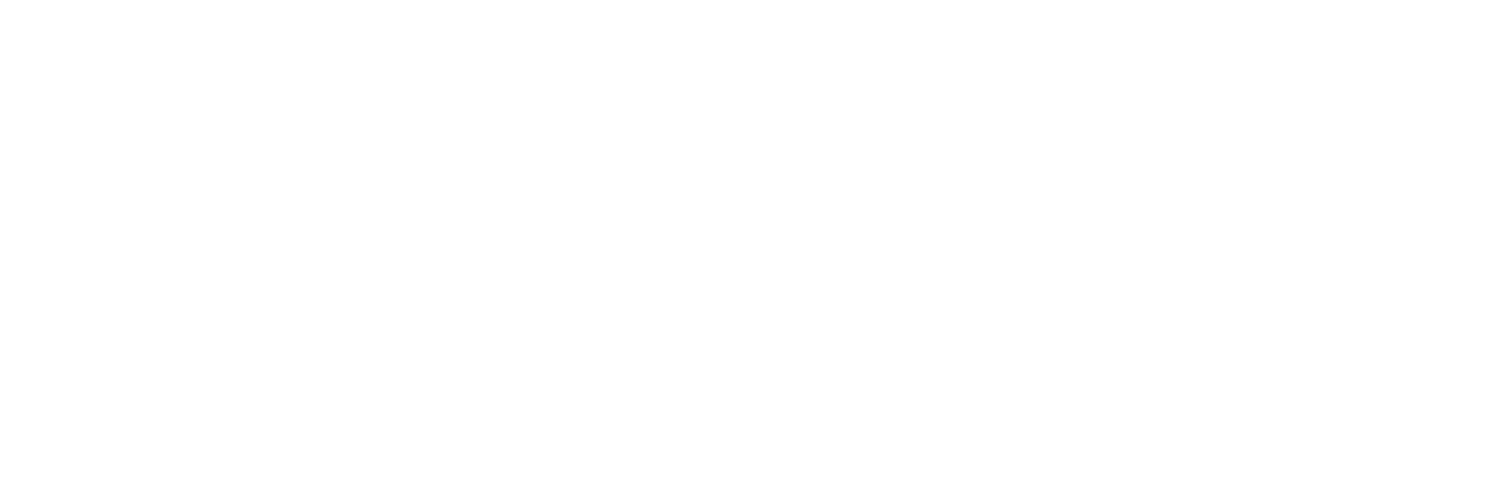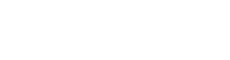In greco, liturgia – λειτουργία – significa azione per il popolo, e anticamente stava a indicare l’imposta dei cittadini ateniesi da versare per le opere pubbliche. Con l’avvento del Cristianesimo, il termine passò ad indicare l’insieme dei riti e delle cerimonie della Chiesa, particolarmente, ma non solo, la Messa e la recita dell’Ufficio Divino. Ma perché si è scelta la parola liturgia? Proprio per ricollegarsi al significato originale greco, almeno nell’etimologia. Se alla celebrazione dei Divini Misteri possono partecipare solo i battezzati, che costituiscono il Corpo Mistico di Cristo che è la Chiesa (Col 1, 24), per i quali è offerto il Sacrificio (per voi), durante la cui offerta si prega anche per i battezzati che si pongono al di fuori della Comunione dei Santi e per i non battezzati (e per molti), viene naturale pensare al rito come un’azione per il popolo, e non del popolo, se non nella misura oggettiva, cioè nella ricezione (il Sacrificio è del popolo perché offerto per il popolo, ma non è del popolo perché offerto dal sacerdote, agente in persona Christi). Non è un caso che durante l’ultima cena, in cui furono istituiti i due Sacramenti, inscindibili l’uno dall’altro, dell’Eucarestia e dell’Ordine sacro fossero presenti solo gli Apostoli. Gesù conferisce alle loro mani il potere della consacrazione, alla loro lingua il potere di costringerlo a cambiare la sostanza del pane nella Sostanza del suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Bisogna qui ricordare necessariamente che gli Apostoli erano uomini, con le loro mancanze e debolezze, tant’è che tra loro c’era anche Giuda Iscariota. Ma Gesù scelse loro come primo nucleo del clero, e Dio porta a compimento l’opera delle sue mani. L’unica senza peccato che avrebbe avuto tutto il diritto di assistervi era Maria, ma era invece assente. Perché il Sacrificio è offerto pro innumerabilibus peccatis, et offensionis, et negligentiis (per gli innumerevoli peccati, offese e negligenze; dal Messale Tridentino), e perché il Sacerdozio è stato posto dalla Sapienza Divina solamente per gli uomini. Nel corso del tempo la liturgia ha subito molti cambiamenti, ma si può comunque dire che un insieme di lasciti antichi e di cerimonie e preghiere precise, insieme ovviamente alla preghiera di consacrazione, sia rimasto pressoché immutato dall’era apostolica all’ultimo Messale prima della Riforma degli anni 1965-1969. Nell’Ordo Romanus I, che descrive la Messa stazionale del papa e fu composto tra il VII e l’VIII secolo, è riportata un’usanza già discretamente antica, quella della santificazione del vino: quando il calice maggiore era pieno, il vino rimanente dell’offertorio era versato in altri calici, più grandi e a due manici; dopo il Pater veniva immessa una parte di Pane consacrato in questi calici, il cui vino veniva santificato dalla commixtio col Corpo di Cristo. Ancora oggi, prima della comunione, nel calice viene messo un frammento di ostia consacrata, e fino alla riforma della Settimana Santa degli anni Cinquanta, al Venerdì Santo si usava porre un frammento dell’ostia consacrata il giorno prima in un calice contenente vino e acqua non consacrati. Anche la stessa posizione del celebrante fu sempre ad Orientem; se nella prima era cristiana l’orientazione era letterale, più tardi si cominciò a renderla figurata. Ma procediamo per gradi.
Caratteri generali sulla posizione del clero
La celebrazione della Messa era divisa in due momenti, la parte didattica e la parte sacrificale. La prima era chiamata anche Messa dei Catecumeni, la seconda Messa dei Fedeli: i catecumeni, infatti, non essendo ancora battezzati, potevano assistere dall’inizio fino al Vangelo, dopo il quale dovevano uscire dalla chiesa, le cui porte venivano chiuse agli occhi increduli. Non potevano, dunque, recitare il Credo né guardare lo svelamento del Mistero, cioè la sistemazione del corporale e lo scoprimento del calice. Durante la Messa dei Catecumeni, parte del clero sedeva nel bema, una struttura rialzata in pietra posta davanti all’altare, nella navata, dalla forma rettangolare con il lato verso la porta semicircolare. Deriva direttamente dal bimah ebraico, in cui sedevano gli anziani e si leggeva la Torah. Il clero sedeva guardando l’altare, dando le spalle alla porta: dato che questa si apriva verso Oriente, interveniva anche la simbologia secondo la quale l’ascesa all’altare, guardando a Oriente, simbolo di Cristo, avveniva dopo il Vangelo e il Credo, con cui si proclamava la Luce e la si confessava (Gv 1, 9). L’orientazione della preghiera, comunque, non era pertinente solo al celebrante, ma a tutti i fedeli, che durante la consacrazione si voltavano a Est, dando di fatto le spalle all’altare. Tutto questo, sia chiaro, avveniva nelle basiliche, mentre nelle chiese più modeste si costruiva un altare, sempre staccato, sul limitare dell’abside, il quale costituiva l’Oriente. Quest’ultimo uso è poi passato alla Chiesa Universale, mentre il primo, non versus populum ma semplicemente ad Orientem, è rimasto nelle basiliche romane, con lo spostamento del bema nell’abside.
La liturgia nella Storia e nel Magistero
Nella Chiesa del periodo precedente a Carlo Magno (800-814) vi era una frammentazione di riti, testi e usanze liturgiche molto diffusa. Lo stesso canto gregoriano non aveva carattere universale, essendo in vigore altre forme musicali, come il canto ambrosiano, il beneventano, il parigino, l’aquileiese o patriarchino. Con la Renovatio Imperii di Carlo, accanto alle pretese unificatrici dal punto di vista politico si unirono quelle religiose, e il risultato fu parzialmente raggiunto. Nel Basso Medioevo permase la pluralità rituale, che fu risolta soltanto con il Concilio di Trento (1545-1563) e la promulgazione del Messale Romano con la bolla Quo primum tempore (1570), con cui si abolivano parimenti tutti i riti che non risalissero a prima del 1370, cioè che non avessero almeno duecento anni. Il Concilio Tridentino, inoltre, per ribadire la dottrina della Chiesa che era stata attaccata dalle idee di Lutero e di altri “riformatori”, ci ha lasciato un encomio della Messa quale è nella propria essenza, e cioè Sacrificio salvifico, offerta per i fini latreutico, eucaristico, propiziatorio e impetratorio. Nella Sessione XXII, del 17 settembre 1562, al Capitolo I, si legge
Poiché sotto l’antico testamento (secondo la testimonianza dell’apostolo Paolo; cfr Eb. 7, 11-19) per l’insufficienza del sacerdozio levitico, non vi era perfezione, fu necessario – e tale fu la disposizione di Dio, padre delle misericordie, – che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech, e cioè il signore nostro Gesú Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati. Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se una sola volta (cfr Eb. 7, 27; 9, 12-26-28) si sarebbe immolato sull’altare della croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non avrebbe dovuto tramontare con la morte, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito (1Cor 11, 23), per lasciare alla Chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech (cfr Sal 109, 4; Eb. 5, 6), offrí a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che l’offrissero, con queste parole: Fate questo in memoria di me (cfr Lc 11, 19; 1Cor 11, 24), ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la Chiesa cattolica. Celebrata, infatti, l’antica Pasqua, – che la moltitudine dei figli di Israele immolava in ricordo dell’uscita dall’Egitto -, istituí la nuova Pasqua, e cioè se stesso, da immolarsi dalla Chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci redense con l’effusione del suo sangue, ci strappò al potere delle tenebre e ci trasferí nel suo regno (cfr Col 1, 3). Ed è questa quell’offerta pura, che non può essere contaminata da nessuna indegnità o malizia di chi la offre; che il Signore per mezzo di Malachia (cfr Mal 1, 11) predisse che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura, al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti; e a cui non oscuramente sembra alludere l’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice (cfr 1Cor 10, 21): che non possono divenire partecipi della mensa del Signore, quelli che si sono contaminati, partecipando alla mensa dei demoni. E per “mensa” nell’uno e nell’altro luogo intende (certamente) l’altare. Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e della legge, era raffigurata con le diverse varietà dei sacrifici: essa che raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento e compimento di tutti essi.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, al n. 10, afferma
[…] La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione; prega affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede; la rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa.
Sempre la Chiesa ha custodito, mediante lo Spirito Santo, ciò che ha di più caro, la presenza reale di Gesù Cristo, e ciò che possiamo auspicare, in questi nostri tempi, è un ritorno alla liturgia: nulla possiamo senza la grazia, che ci viene comunicata attraverso i tesori sacramentali. Torniamo al Signore con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, perché il Signore si mostri geloso della sua terra e si muova a compassione del suo popolo (Gioele 2, 12-18).