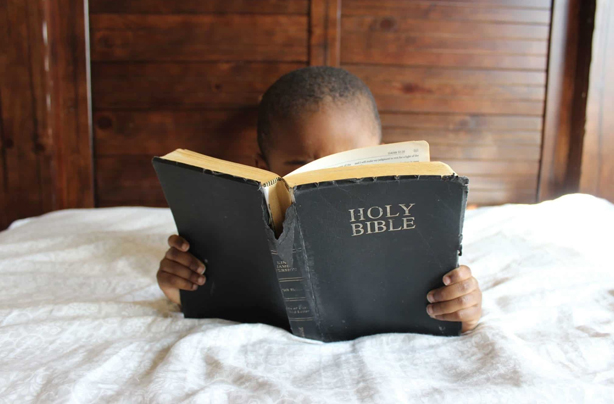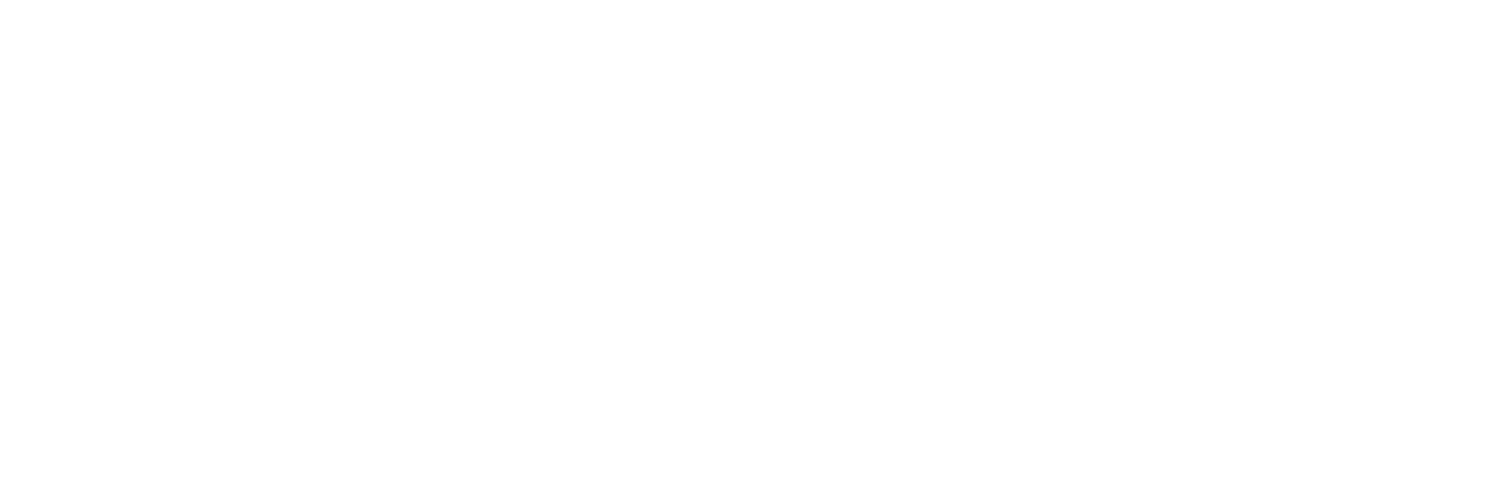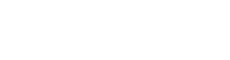[page_title]
Nel novero delle inspiegabili sparizioni conciliari l’ora Prima occupa un posto speciale. Che valore ha, invece? Un inutile peso?
Se il fosco programma Chi l’ha visto? ricercasse anche le scomparse causate della squadra di Bugnini, troverebbe tra le sue vittime l’ora Prima. Già, un’intera ora canonica è stata cancellata, per motivi profondamente importanti dal punto di vista teologico e pastorale: sì, davvero. I motivi…sì insomma, «L’ora di prima sia soppressa» (cfr. Sacrosanctum Concilium num. 89/d): così, de botto, senza senso; in una costituzione conciliare ampiamente dettagliata si cassa un’intera ora senza dare uno straccio di motivazione. I cattolici fedeli alla Tradizione, però, continuano a pregare quest’ora sull’insegnamento dei Padri, memori che ciò che ha santificato la vita di secoli di cristianesimo non può essere cancellato dal genio di turno degli anni Sessanta (a proposito: ritenersi un genio assoluto contro un passato di ignorantoni è una forma di mitomania che va curata).
Il termine deriva dall’antica computazione ebraica e latina del tempo, secondo la quale le ore sono contate non dalla mezzanotte ma dall’alba. Così, secondo l’idea originaria, le Lodi si pregano all’alba (con il Benedictus al sorgere del sole) e Prima un’ora dopo. Nella prassi quotidiana è possibile semplicemente pregarle dopo Lodi, possibilmente (mio suggerimento) prima delle 9, quando si entra già nell’ora Terza. Bisogna infatti considerare che l’ufficio del Mattutino (non a caso strutturato per Notturni) risponde al versetto «Media nocte surgebam ad confitendum tibi» (Ps. CXVIII 62), mentre le altre sette ore a «Septies in die laudem dixi tibi» (Ps. CXVIII 164). Secondo S. Giovanni Cassiano nacque nel monastero di Betlemme.
L’ufficio è strutturato con l’introduzione solita delle ore, l’inno composto da S. Ambrogio (Iam lucis orto sidere), la salmodia a tre salmi con unica antifona, il capitolo, il responsorio, le preci (nei giorni dal Semidoppio compreso in giù), il simbolo atanasiano (quando si celebra l’ufficio domenicano), l’orazione, il martirologio del giorno successivo seguito da una serie di versetti.
Ritengo particolarmente interessante la pratica di recitare il Martirologio con tutti i santi (anche quelli che poi non saranno celebrati perché iscritti al Martirologio ma non al calendario liturgico) del giorno successivo, per dare già una preparazione del giorno successivo, con le feste che inizieranno infatti nel Vespro successivo. Ogni Santo viene indicato con la provenienza geografica (con gustosi locativi in latino) e con l’evento che lo riguarda (la morte, la traslazione delle reliquie…).
Considerando metaforicamente i prodotti finali delle tradizioni liturgiche come dei codici manoscritti e applicando i criteri della filologia potremmo provare a rispondere ad una domanda storica. Dal momento che l’ora Prima è ancora pregata da ortodossi greci, ortodossi russi, copti, armeni, siriaci ma non dai cattolici, qual è il “manoscritto” riportante la lezione errata? È evidente che l’archetipo storico contenesse anche Prima, poi eliminata dal copista romano conciliare. Ah, tanto per la cronaca: fu soppresso anche dal Book of Common Prayer della “chiesa” anglicana, ma è chiaro che si tratti di una coincidenza; nessun legame tra gli eretici di Albione e il fan club di Bugnini, solo piccoli elementi comuni come l’uso della lingua volgare, l’orientamento dell’altare, la foggia dei paramenti, la distribuzione della comunione, la struttura del canone, insomma, nulla di che. Ma di questo si parlerà successivamente, per ora riprendiamo a recitare Prima, come fecero S. Giovanni Cassiano, S. Benedetto, S. Ippolito di Roma, S. Pio V e tanti altri santi, ad majorem Dei gloriam.