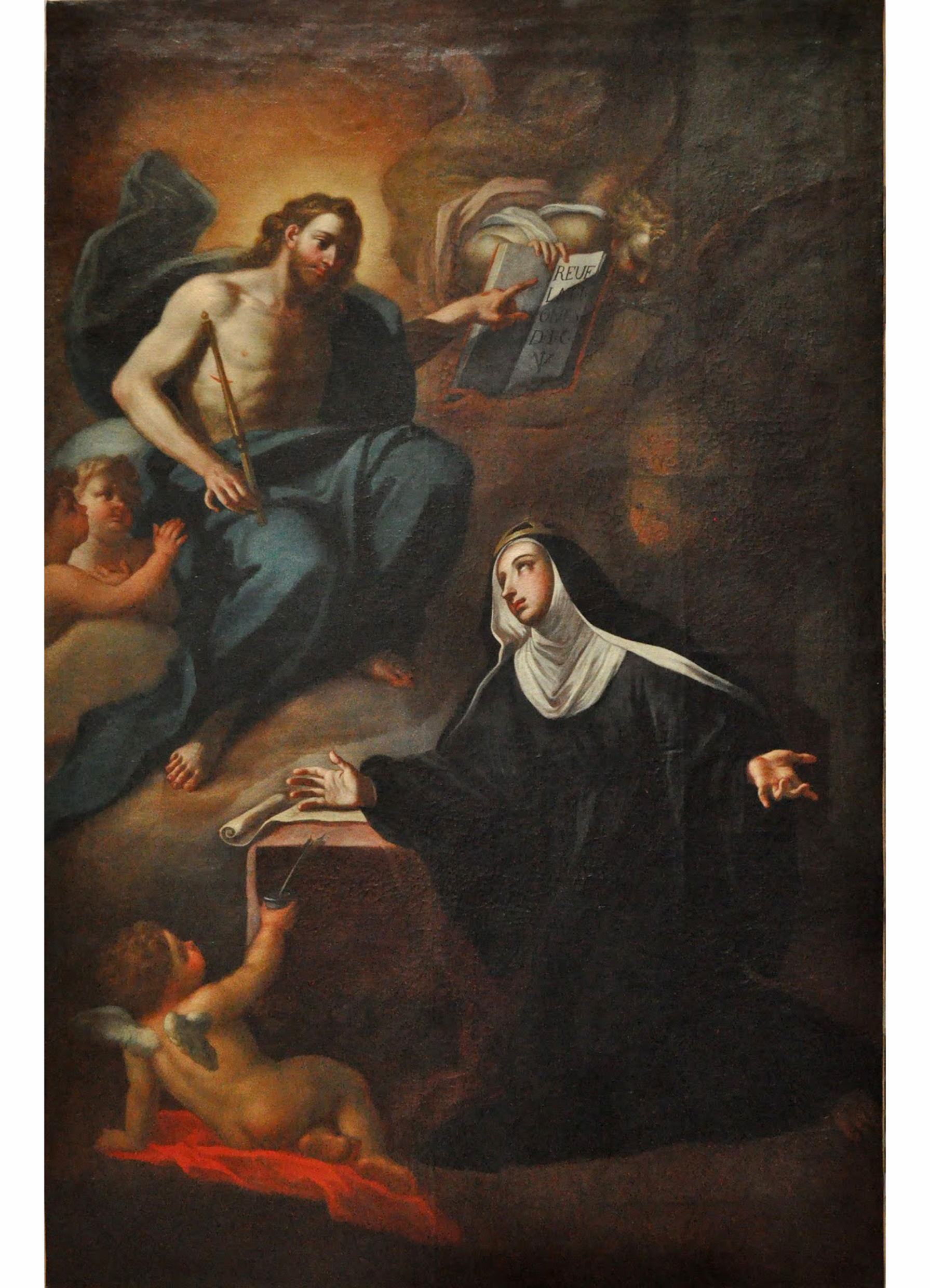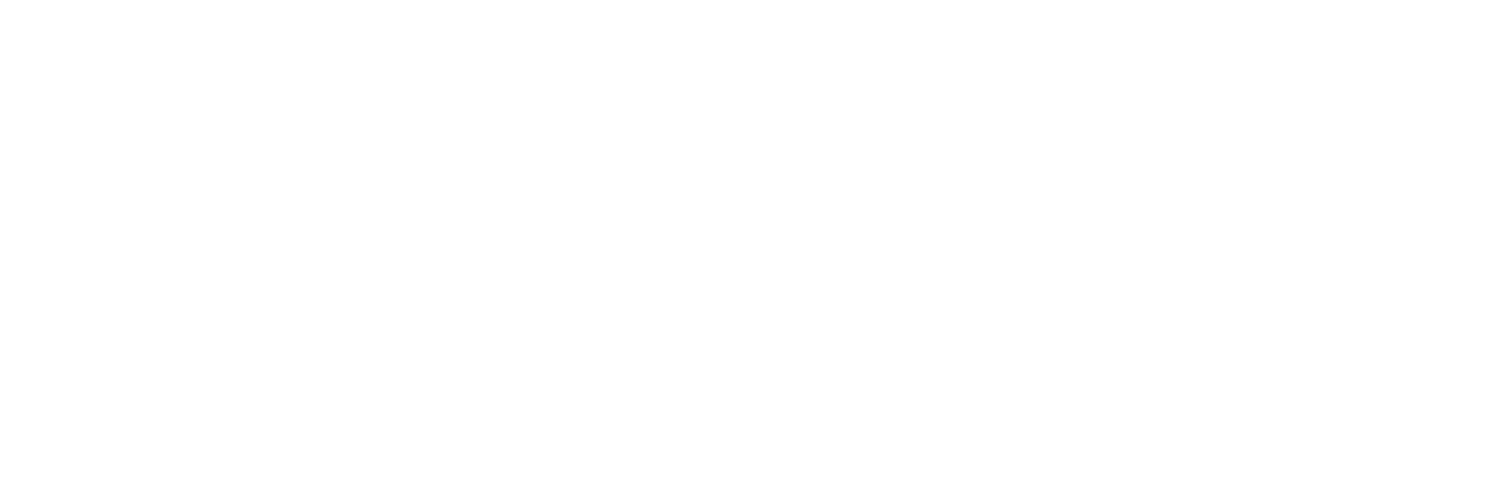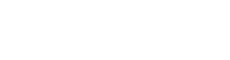[page_title]
Vi è un antefatto del dramma. Quando Adamo peccò l’uomo dalla Divina Foresta dell’innocenza (che è il Paradiso Terrestre posto sulla cima del Purgatorio), cadde nella selva oscura della «ignorantia», stato di chi ha perduto lo «scire recte» (retta conoscenza) e quindi la visione del vero bene.
Inferno – Canto I
Vi è un antefatto del dramma. Quando Adamo peccò l’uomo dalla Divina Foresta dell’innocenza (che è il Paradiso Terrestre posto sulla cima del Purgatorio), cadde nella selva oscura della «ignorantia», stato di chi ha perduto lo «scire recte» (retta conoscenza) e quindi la visione del vero bene. Quella selva è oscura perché è appunto offuscamento della visione del vero bene, ed è «tanto amara che poco è più morte» appunto perché da essa si cade nella morte dell’anima. L’uomo potè uscire da quella selva soltanto per mezzo di un misterioso «passo», che non lasciò giammai persona viva (Inf., I, 27), un «passo» cioè nel quale si muore, si muore misticamente, e questo «passo» è il battesimo nel quale il cristiano, per i meriti di Cristo, per la virtù della rivelazione che emana dalla Croce, può, misticamente morendo in Cristo, riacquistare lo «scire recte», vincere l’ignorantia derivante dal peccato originale e cioè uscire dalla selva. Uscito così dalla selva egli acquistava la coscienza della mèta che prima aveva smarrito, sapeva dove giungere, cioè sapeva che doveva ritornare alla originale innocenza, che è sulla cima di un monte, e di lì a Dio. Ma egli per il peccato oltre alla capacità di «scire recte» aveva perduto anche la capacità di «recte facere», era affetto non soltanto dalla ignorantia ma anche dalla difficultas. E dopo superata l’ignorantia che è una selva, doveva superare anche la difficultas che è una piaggia (= pendio). Su questa piaggia egli trovava la guida imperiale che lo sanava con la virtù dell’Aquila dopo che al «passo» egli era stato sanato con la virtù della Croce e gli rendeva il «recte facere» dopo che la Croce gli aveva reso lo «scire recte», lo sanava della difficultas dopo che la Croce lo aveva sanato della ignorantia, lo sanava per la vita attiva dopo che la Croce l’aveva sanato per la vita contemplativa. Allora l’uomo poteva affrontare tutto il cammino che dalla selva oscura riconduce alla divina foresta, dal peccato originale alla originale innocenza.
Ed ecco quasi al cominciar dell’erta
(Inf., 1, 31)
una lonza leggiera e presta molto
che di pel maculato era coverta.
Dante l’aveva sempre dinanzi al volto e ne era impedito nel suo cammino, sì che si volse più volte per ritornare. Ma era mattina, era primavera: l’ora e la stagione gli erano motivo a bene sperare; quando apparve un leone, con la test’alta, con fame rabbiosa da spaventar l’aria, e una lupa, magra, piena di tutte brame, che fece misere molte genti. Queste due, specialmente l’ultima, lo impaurirono: alla vista dell’ultima perdè la speranza di salire. Egli piange e s’attrista in tutti i suoi pensieri; nessuno gliene rimane a confortarlo. La bestia senza pace gli veniva incontro a poco a poco respingendolo nell’oscurità e facendolo ruinare nella bassura di prima. Quando gli si mostrò un’Ombra. Era respinto nell’oscurità; e l’Ombra era d’un poeta onore e lume di tutti i poeti. Era ricacciato nella selva dove non è “vita di scienza e d’arte”; e l’ombra era d’uno che onorava ogni scienza ed arte. (Inf. 4, 73) Ruinava in basso loco; dove sono i parvoli d’animo; e del magnanimo era l’Ombra. Le tre fiere che sono? Perchè la selva che impediva Dante, e gli mise tanta paura, rappresenta il peccato, è ragionevole figurino il peccato anche le fiere che impediscono e impauriscono. Ma la selva è il peccato originale; le fiere saranno il peccato attuale. Il peccato attuale presso Dante (e presso tutti) è tenuto separato dal peccato originale. In vero Virgilio, dichiarandolo e dividendolo filosoficamente, non fa parola del limbo e del vestibolo, e parla solo di incontinenza, violenza (o bestialità), frode. Così: prima parla solo di malizia divisa in vim e fraudem, secondo Cicerone, e la frode suddivide poi in tale che uccide solo il vincolo d’amore e in tale che fa obliare anche l’amore aggiunto per fede speciale; in tale, secondo una distinzione pur Ciceroniana, che offende l’umanità e in tale che offende la pietà (pietas).
Quando, chiedendone Dante, Virgilio mentova l’incontinenza che offende meno Dio e acquista meno biasimo, ed è punita perciò fuor di Dite, allora enumera le tre disposizioni aristoteliche, incontinenza, malizia e la matta bestialità. Che la bestialità sia tutt’uno, per Dante, con la violenza certo, e parole non ci appulcro. Le disposizioni sono tre, come le fiere; le fiere raffigurano il peccato; saranno dunque queste tre specie di peccato.
Si opponevano a lui tre fiere, le tre disposizioni cattive, le tre forme del peccato attuale: l’incontinenza, amore del falso bene sotto forma di lonza si opponeva per prima, peccato più lieve e con forme e colori allettanti ma il cristiano, in quanto la virtù della Croce gli ha rivelato il bene vero e in quanto per essa egli si volge al sole e al cielo coi quali ci chiama Iddio, può bene sperare della lonza. L’incontinenza però, che è soltanto corrotto appetito, diventa bestialità, corruzione dell’appetito e della volontà sotto forma di leone, e la bestialità diventa malizia, corruzione dell’appetito, della volontà e anche dell’intelletto, sotto forma di lupa. Ciascuna delle fiere sparisce nell’altra che la comprende cosicché da ultimo resta innanzi all’uomo soltanto una lupa. Ma per vincere questa non basta la conoscenza del vero bene che viene dalla Croce e che bastava contro la lonza. Essa, come corruzione della volontà e dell’intelletto, come volontà di fare ingiuria cioè come ingiustizia può essere vinta solo dalla virtù dell’Aquila cioè dall’Impero. E infatti contro di essa operava l’Impero, l’Aquila, la quale, strumento della divina giustizia, non solo faceva da guida all’umanità sanandola della difficultas, guidandola sulla «piaggia», ma teneva sgombra la via della redenzione vincendo l’ingiustizia, ricacciando nell’Inferno la lupa che avesse osato porsi sulla via, mentre la Croce aveva sanato l’uomo dalla ignorantia (la selva) e gli aveva dato potere di vincere la concupiscenza (la lonza). In tale ordine di cose facile e aperta era la via dalla selva alla foresta perché delle due conseguenze del peccato originale: ignorantia (selva) e difficultas (piaggia) l’una si superava per la virtù della Croce, l’altra per la virtù dell’Aquila e delle due categorie del peccato attuale la concupiscenza (lonza) si superava per la virtù della Croce e l’ingiustizia (lupa che comprende anche il leone) si superava per la virtù dell’Aquila. Ma da quando non esiste più l’Impero questo cammino è impedito. La piaggia dove dovrebbe essere la guida imperiale è deserta (Inf., I, 29); manca l’opera dell’Aquila: l’Impero non fa da guida per vincere la difficultas e non è presente per ricacciare nell’Inferno l’ingiustizia cioè la lupa. Questa si è messa sulla via della redenzione e la sbarra. Così l’uomo, poiché è impedita la via della redenzione mentre già, essendo adulto, dovrebbe essere avviato alla «divina foresta» dell’innocenza, per il fatto che la via è smarrita si ritrova (ancora) nel mezzo del cammino della sua vita, ricacciato nella selva oscura. Il dramma di Dante è destinato appunto a mostrare come e perché l’uomo, pur avendo la Croce, sia ricacciato nella selva oscura e rischi di perdersi per la mancanza dell’Aquila. Egli, nelle presenti condizioni del mondo, avendo la Croce supera sì il «passo che non lasciò giammai persona viva» (v. 27) attuando in sé la virtù del battesimo e, dopo superato quel «passo», guarda in alto (v. 16) e vede il monte sulla cui cima è la felicità. È stato sanato della ignorantia per virtù della Croce: ha riacquistato lo «scire recte». Ma se è sanato nello spirito, il suo corpo è lasso (v. 28) ed egli riprende la via sì, ma la riprende per una piaggia che è deserta (v. 29) senza guida. Egli avrebbe bisogno per procedere bene di essere sanato non solo della ignorantia, ma anche della difficultas, non solo dalla virtù della vita contemplativa ma anche da quella della vita attiva; è sanato soltanto dall’una e perciò egli procede sicut claudus, come zoppo. Così (trasmettendoci una chiosa indiscutibilmente paterna e che non poteva essere inventata) interpreta Pietro di Dante il verso «Sì che il piè fermo sempre era il più basso» (v. 30). L’anima deve essere sanata nei due piedi coi quali procede: quello della vita attiva e quello della vita contemplativa. Dante, sanato soltanto per la vita contemplativa, ha un piede infermo e quindi cammina sicut claudus, come zoppo. Il piede sano, fermo, è più basso, poggia bene sulla terra, quello infermo (come tutti i piedi infermi) poggia male ed è quindi più alto (si ricordi il Veglio di Creta (Inf., XIV) che rappresenta proprio la condizione dell’umanità presente anch’esso infermo da un piede e precisamente dal piede sinistro che dovrebbe essere sanato dall’Impero). L’uomo sanato così solo in parte dagli effetti del peccato originale, affronta la lotta col peccato attuale, ma può vincendo solo in parte. Avanti agli allettamenti della lonza, amore di falso bene, concupiscenza, egli alza gli occhi al sole che sorge nel mattino di primavera, al richiamo di Dio verso il bene vero e quindi può bene sperare di lei (v. 41), può sperare di vincerla perché la virtù della Croce ha operato in Iui al «passo». Ma quando l’amore fallace, la cupidità si liqua in mal volere (Par., XV, 3) diventa cioè malizia o ingiustizia, malizia con forza e con frode (leone e poi subito lupa) allora la virtù della Croce sola non può dargli la vittoria. Allora la lupa, malizia o ingiustizia, lo assale e lo ricaccia indietro; non solo gli impedisce di bene operare, ma lo atterrisce perché con la paura che esce «dalla sua vista» (v. 53) gli fa perdere la speranza dell’altezza (v. 54). L’uomo, avanti allo spettacolo dell’ingiustizia trionfante nel mondo, e nella impossibilità di operare il bene, rischia di perdere anche la speranza che gli è data dalla fede in quanto rischia di dubitare dell’ordine santo di Dio. In tal modo la lupa, non vinta dall’Aquila, minaccia di far perdere all’uomo anche la virtù santa che egli ha acquistato per opera della Croce, lo respinge «là dove il sol tace», cioè nella «selva», là dove l’uomo perde anche la visione della meta santa dei cieli, perde la fede e la speranza acquistate con la Croce e si smarrisce nel sonno, in quel somnus animae che (secondo Agostino) è un oblivisci Deum (v. 11) e che, per poco che si aggravi, diventa morte, morte dell’anima, perdizione. Ora sappiamo come e perché, essendo la diritta via smarrita nel mondo, mancando nel mondo l’Aquila che faccia da guida sulla «piaggia» e vinca l’ingiustizia, l’uomo è di fatto come non redento, e ricacciato (di nuovo) nella selva oscura dove rischia di perdersi poiché smarrisce la virtù illuminante della Croce. Ma ecco apparire provvidenzialmente chi possiede la virtù dell’Aquila necessaria a chi abbia soltanto la Croce: Virgilio. Nella presentazione che egli fa di se stesso egli ricorda di essere nato «sub Julio» e di aver vissuto «sotto il buono Augusto», «al tempo degli dei falsi e bugiardi» (v. 72). A Dante, all’umanità presente, che per virtù della Croce conobbe il Dio vero, ma non può percorrere la via della salvazione perché gli manca «il buono Augusto», la virtù dell’Aquila, egli si presenta come colui che non conobbe il Dio vero, ma ebbe la guida del «buono Augusto», che non ebbe la Croce ma ebbe sì l’Aquila. Egli spiega a Dante che la via dalla selva alla foresta, cioè la via della redenzione è sbarrata perché manca l’Aquila: in assenza dell’Aquila l’ingiustizia, la lupa si è messa sulla strada e non lascia passare gli uomini alla salvezza, anzi l’impedimento è tale che li uccide, fa cioè in modo che essi si dannino (v. 96).
Essa, l’ingiustizia, si unisce a ogni specie di peccati (si ammoglia con molti animali) e continuerà a impedire agli uomini di passare fino al giorno in cui il Veltro, il restauratore dell’Impero, non riporti sulla «piaggia», ora deserta, la virtù dell’Aquila, la quale sola, essendo strumento della Divina Giustizia, può vincere la ingiustizia. E questo restauratore dell’Impero riporterà l’ordine santo nel mondo e salverà il mondo e l’Italia da tutti i suoi mali. Finché non torni l’Impero con la virtù dell’Aquila il «corto andare» della vita attiva è pertanto impedito dalla dominante ingiustizia. Il cammino della salvazione non si può percorrere operando come si dovrebbe. Si può percorrerlo soltanto in contemplazione e in visione cioè per un «altro viaggio» (v. 91) che rappresenta appunto la stessa via della salvezza percorsa però in contemplazione e in visione e che come vedremo parte nuovamente dalla selva, supera l’antica ignorantia al «passo» dell’Acheronte ove si muore misticamente, per la virtù della Croce, supera poscia facilmente l’inferno dell’incontinenza (lonza), trova che l’inferno dell’ingiustizia (mura di Dite) resiste perché manca l’Aquila ma sopraggiunge la virtù dell’Aquila nella persona di Enea l’instauratore dell’Impero, a infrangere l’ingiustizia per colui che alla giustizia è fedele. Si vince così per la virtù dell’Aquila anche l’ingiustizia, e poi si sale un monte sulla cui cima l’uomo è felice e che è misticamente lo stesso monte ai piedi del quale Dante si trova ora e che è «principio e cagion di tutta gioia». Per la virtù della Croce è possibile al cristiano percorrere non in operazione, ma in spirito la via della salvazione; ma egli la vedrà quale essa veramente è, cioè una via che non può essere percorsa da chi sia sanato soltanto dalla «ignorantia» e non anche dalla «difficultas», da chi abbia la Croce sola e non l’Aquila e perciò Dante che ha la Croce sola, non la può percorrere se non abbia accanto a sé, guida e sostegno, Virgilio che fu sanato dall’Aquila. E così due sono i poeti che si avviano a compiere il sacro viaggio, due che s’integrano a vicenda, l’uno che ha il Cristo, l’altro che ebbe il buon Augusto, uno che è destinato alla meta santa dei cieli, ma l’altro che è necessario per indicargli la via, uno sanato nella contemplazione, l’altro nell’operazione, l’uno sotto il segno venerabile della Croce, l’altro sotto il sacrosanto segno dell’Aquila.