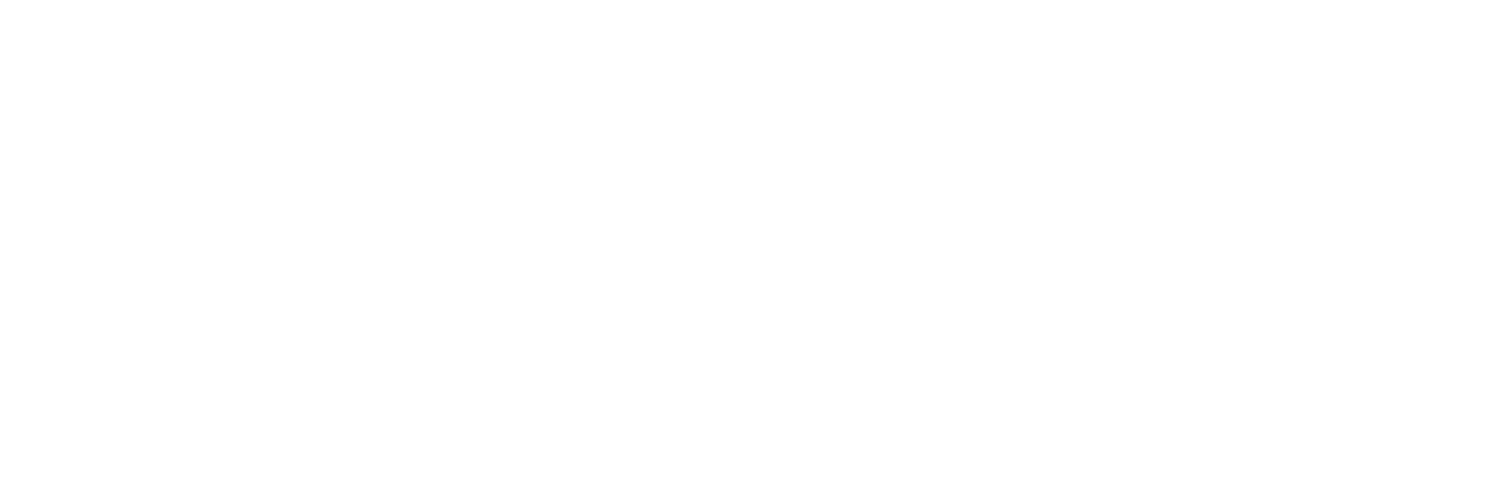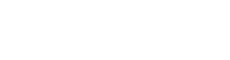L’organum
Dopo una importante parentesi come il canto gregoriano, affrontiamo un altro importante “pezzo” della storia della musica, dove ancora una volta vediamo che è la musica sacra ad essere protagonista.
Le prime testimonianze medioevali di polifonia sacra le abbiamo in Francia (intorno al 1100) con l’organum, cioè una seconda voce che accompagna un cantus firmus (il cantus firmus molto spesso era un canto gregoriano). L’organum poteva essere di 3 tipi:
- organum parallelo, dove la melodia procede per quarte
- organum libero, dove alla voce principale (tenor) è aggiunta una seconda voce “a piacere”
- organum melismatico, dove alla voce principale (tenor) è aggiunta una seconda voce che invece di procedere omoritmicamente, effettua un grande melisma.
La polifonia a Notre Dame
Proprio in Francia, i teorici di Notre Dame dell’epoca (tra cui Léonin, Pérotin e l’Anonimo IV) elaborarono per la prima volta un criterio di misurazione della durata dei suoni, introducendo il concetto di due note di diverso valore: la longa e la brevis. La suddivisione di ogni modo ritmico è ternaria e perfetta (perché per l’epoca la ternarietà era simbolo di perfezione, riferimento alla trinità).
Quindi, una longa non ha un valore fisso, ma poteva essere scomposta in 2 o 3 brevi a seconda del modo in cui appartiene.
I primi modi ritmici erano 6, così classificati:
- Longa + Brevis
- Brevis + Longa
- Longa + Brevis + Brevis
- Brevis + Brevis + Longa
- Longa + Longa
- Brevis + Brevis + Brevis
Le prime forme della polifonia
Inizialmente, alcune parti polifoniche venivano realizzate nell’antico stile dell’organum parallelo o melismtico. Ci sono varie forme polifoniche che sappiamo essere state utilizzate a quell’epoca, tra queste abbiamo:
- Clausola: è una sezione polifonica fondata su una parola o a volte solo su una sillaba del testo, dove il tenore procede più lentamente rispetto alla voce superiore ma senza avere note lunghe e mantenendo ancora un un ritmo misurabile (questo stile è chiamato discanto).
- Conductus: è un brano accessorio alla liturgia, che nacque per accompagnare i movimenti del celebrante (in questo brano, lo stile è sillabico).
- Mottetus: probabilmente deriva dalla clausola ed è formato da più voci (Tenor la voce “più grave”, seguito dal duplum, dal mottetus, dal triplum e probabilmente anche dal quadruplum) dove inizialmente i testi erano di destinazione liturgica ma successivamente ebbero diversi interessi, anche profani.
- Hoquetus: si riferisce ad una tecnica compositiva che consiste nell’alternare note e pause nel corso della linea melodica.
Suggerimenti di ascolto
Organum parallelo: link
Organum melismatico: link
Mottetus: link