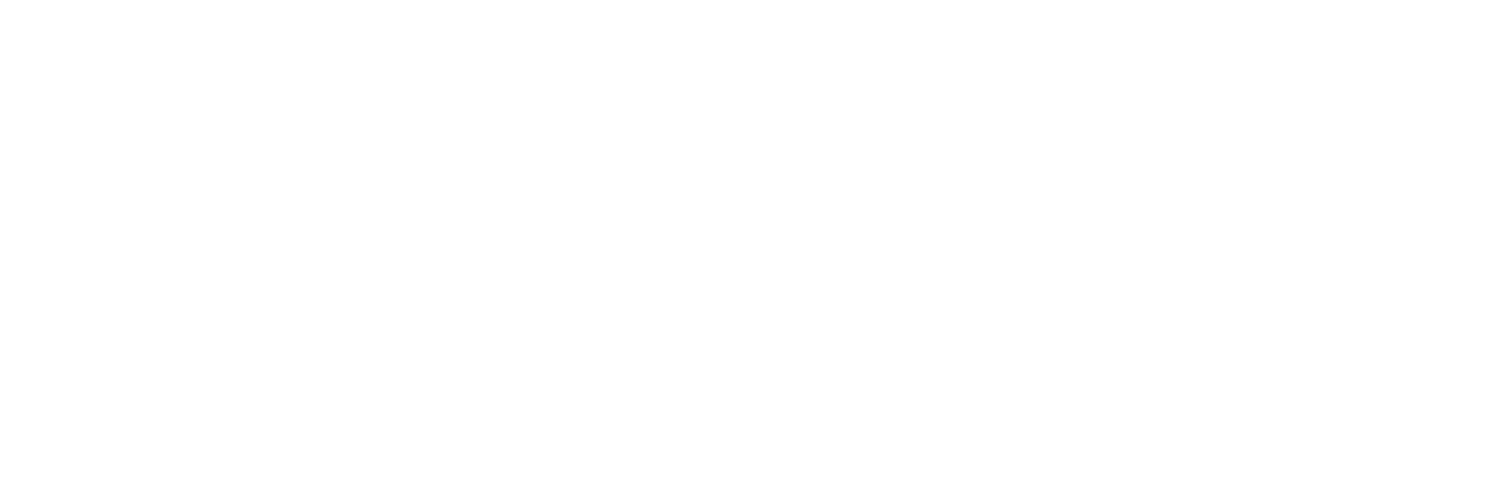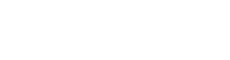La misericordia di Dio è grande, infinita e inesauribile. Essa costituisce, come disse Gesù a santa Faustina Kowalska, l’apostola della “divina misericordia” dello scorso secolo, il primo e più grande attributo della divinità, per cui possiamo e dobbiamo dire, credere e sperare che Dio desidera darci il suo perdono molto più di quanto possiamo volerlo o desiderarlo noi. La testimonianza di carità infinita data dal suo Figlio Unigenito, che ha indicibilmente patito ed è morto al posto nostro, pagando i nostri debiti, giusto per gli ingiusti, è quanto mai chiara ed emblematica. Dubitare della divina misericordia sarebbe offendere gravemente il Signore.
Tuttavia, detto e affermato con forza quanto sopra, bisogna immediatamente aggiungere che oggi purtroppo capita non di rado di veder circolare una strana e del tutto inaccettabile dottrina della divina misericordia che la trasforma da strumento mirabile di salvezza a vera e propria autostrada verso la perdizione. Per guardarsi da ciò, bisogna anzitutto ricordare un principio semplicissimo: Dio perdona tutto, sempre e tutti a condizione che il peccatore sia realmente e profondamente pentito, ossia detesti il peccato con tutto il cuore, si dolga di averlo commesso e, al tempo stesso, abbia il fermo e risoluto proposito di non farlo mai più. In caso contrario, le colpe rimangono attaccate all’anima del peccatore e un’eventuale confessione rischia di diventare solo un tentativo (forse non del tutto consapevole, ma non per questo non grave) di prendersi gioco dimostro Signore. Tale requisito è completamente interiore al penitente; nel senso che, a meno di doni e carismi straordinari, il confessore può solo verificare, sulla base di ciò che emerge oggettivamente e esternamente in sede di confessione, se il peccatore sembra pentito oppure no; in caso positivo deve assolvere il penitente, mentre, in caso negativo, prima di rimandare l’assoluzione, deve fare il possibile per suscitare il pentimento in sede di confessione, aiutando il penitente quanto meno a prendere coscienza della gravità del peccato, del male che esso genera e dei debiti verso la divina giustizia che esso causa. Tuttavia se il fedele afferma di essere pentito e di essere disposto a non più peccare, il sacerdote non potrebbe, senza prendersi una grave responsabilità, ritardare o addirittura negare l’assoluzione. Fermo restando che, qualora il penitente avesse affermato il falso, si macchierebbe di gravissimo peccato e la sua confessione sarebbe, contemporaneamente, nulla (nessun peccato gli sarebbe rimesso) e sacrilega (dando luogo al gravissimo peccato di sacrilegio).
L’importanza capitale di questo punto può essere meglio compresa se si medita sulle modalità con cui i sacerdoti muniti di doni straordinari (soprattutto quello della “cardiognosi”, ovvero della capacità di leggere l’interno della coscienza e del cuore dell’uomo) amministravano questo sacramento, negando assai spesso l’assoluzione. San Pio da Pietrelcina, per esempio, la negava spessissimo proprio a causa della mancanza di pentimento che vedeva nel cuore del penitente. Stessa cosa vale per il santo Curato d’Ars e per san Leopoldo Mandic, pur essendo quest’ultimo, a detta di tutti i testimoni, un campione di dolcezza e carità. Per questo motivo sembra quanto mai accettabile la definizione che qualcuno, sulla scia di una certa tradizione ecclesiale, dà di questo sacramento, chiamandolo “sacramento della conversione”, nel senso che richiede e, al tempo stesso, sigilla una scelta profonda di cambiamento, sia nella mentalità che nei comportamenti di vita (secondo la duplice etimologia possibile, greca o ebraica, del temine “conversione”, in greco “metanoia” = cambiamento di mentalità, in ebraico “teshuvà” = cambiamento di direzione, ritorno sui propri passi. Facendo qualche esempio, chi fa la confessione di Pasqua nella situazione di essere un “disertore” abituale della Santa Messa domenicale, è inutile che si confessi se non ha un minimo proposito quanto meno di provare a riprendere la regolare frequenza alla santa Messa festiva. Stessa cosa si dica per i bestemmiatori abituali, per i lussuriosi e, in generale, come insegna sant’Alfonso, per i peccatori “recidivi”, ossia quelli che, ottenuta l’assoluzione, tornano a commettere a cuor leggero proprio il peccato o i peccati gravi da cui sono stati assolti. Il grande Dottore, patrono dei confessori (seguito in questo “ad litteram” da san Pio), insegnava che un’ulteriore caduta può essere perdonabile, ma già ad una terza caduta, senza che ci siano stati segnali oggettivi di progresso (tempo trascorso, altre occasioni di peccato vinte, etc.), l’assoluzione immediata diventa alquanto problematica, perché pone il confessore nel pericolo di rendersi complice del peccato di sacrilegio. Se pentimento non c’è bisogna percorrere due vie: quella della preghiera e quella della buona formazione, entrambe dirette a provocare nel cuore del peccatore indurito il risveglio di una coscienza che sappia riconoscere e detestare il male e starne lontano come dalla peste. Appena questo accade, si corra pure immediatamente a ricevere l’abbraccio del Padre misericordioso, che, come ci insegna la famosa parabola del Vangelo di san Luca, appena nota il “rientro in sé e il tornare indietro” del figlio peccatore, si affretta a corrergli incontro e a offrirgli il perdono prima ancora che possa parlare. Si mediti dunque sull’importanza e la grandezza del pentimento, che, quando è sincero, ottiene il perdono dell’Altissimo prima ancora di chiederglielo!